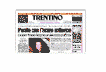| |
|
| |
|
|
Rebora
La sua
chiarezza
in cinque saggi al «Rosmini»
«Clemente Rebora e i maestri in ombra»
è l'ultimo dei Nuovi Quaderni Reboriani.
È stato presentato al Centro Rosmini di
Trento.
|

Pasolini, al centro del
quaderno reboriano presentato al
«Rosmini»
|
|
| |
|
di Alessandro
Dell'Aira
---------------------------------
IL «QUADERNO» contiene otto scritti vecchi e
nuovi tra cui regna sovrano l'ottavo, pubblicato
su "Il Punto" nel 1956 e dedicato da
Pierpaolo Pasolini ai «Canti dell'infermità»
di Clemente Rebora. Saggio sovrano perché dà il
la al concerto dei nuovi reboriani (cinque) e
ispira il titolo del terzo quaderno con
l'ossimoro lucido e immaginoso - «come dire»,
premette garbatamente Pasolini quasi a chiedere
perdono - «dei "maestri in ombra"», i
vociani che sulla via dell'ermetismo, nel mutare
di penne dei poeti, rimanevano indietro, al
margine, nel girone dei sopravvissuti, fuori del
tempo proprio ma anche e in primo luogo, come si
amava già dire nel'56, fuori del tempo e della
storia tout court. Cinque saggi nuovi e
tre scritti antichi di Gian Carlo Ferretti
(rielaborato per l'occasione), Piero Jahier e
Pierpaolo Pasolini, di cui abbiamo detto, con
ritratti diretti e indiretti di Rebora
intellettuale laico milanese in gioventù e prete
rosminiano roveretano in vecchiaia, dal' 45 in
poi. I saggi nuovi sono di Gualtiero De Santi
(Una generazione al buio), Giuliano Ladolfi (Son
l'aratro per solcare), Enrico Grandesso (Varcare
il silenzio: annotazioni critiche), Franco Lanza
(Jahier vociano e reboriano), Attilio Bettinzoli
(Rebora e Campana). Sempre e tutti impegnati, gli
autori, a collocare Rebora da-a, o tra-e: da
vocianesimo a rondismo, dall'anonimato
all'infermità spirituale, tra facce ambigue e
facce pitturate, tra l'attesa e la vita, tra
l'etica e l'atto poetico.
Antidannunziano, senilmente antiletterario nella
sua religiosità, sedotto ancora dalla parola
poetica dopo un silenzio di vent'anni, Rebora
appare a Pasolini come il poeta che ha vegliato
una notte sola barricato nella vita interiore,
meditando sul rumoroso dilettantismo di Soffici
Papini Prezzolini, dominando la lingua e domando
l'ispirazione. Sulla schiena di Rebora, che amava
dipingersi come un asino dall'allegro basto e
dalle nari fruscianti, incombe la stanchezza di
una malinconia disperata. Siamo nel 1907, lui è
un poeta creativo e a volte incomprensibile tanto
che Alfredo Panzini lo supplica di scrivere
chiaro per farsi capire. Perché non vuol farsi
capire un giovane poco più che ventenne come
lui, che ha talento e capacità, perché si
impunta come un somaro e si ostina bizzarramente
a fare l'esatto contrario del Carducci, il
maestro perennemente al sole che vaticina,
rigurgita e canta ore rotundo? Cosa c'è di più
bello della chiarezza? Rebora, dicono i suoi
detrattori, sarà maestro di etica ma come poeta
non è chiaro, e mai lo sarà, per quella sua
mania espressionista del voler fare violenza alle
parole, del transitivizzare contro natura i verbi
intransitivi, del consapevole pasticciare con i
sensi, con la semantica e con le figurine della
retorica. E' schiavo, dicono, come gli altri
amici suoi, della licantropica mania del voler
camminare soli al sole per fuggire dalla
chiarezza compatta del giorno, per cercare
l'ombra e frantumarla, ovunque, anche nel più
monolitico dei settenari leopardiani. Colpa o
certezza? La decadente certezza intellettuale di
Rebora e dei reboriani consiste nella paziente
ostinazione del voler cercare e non trovare i
perché delle cose nei recessi polverosi
dell'esperienza poetica universale, ripetendo
"perché", "perché",
"perché", fino a quando la mente non
si arrende e l'orecchio abbacinato non avverte il
mistero del verso nuovo. Dissodare la lingua, il
lessico e lo stile. Siamo aratri per solcare, ma
nell'ombra, e sono Boine, Jahier, Rebora e
Sbarbaro. Voci maestre di quei quindici anni
difficili.
-----------------------------------
|